

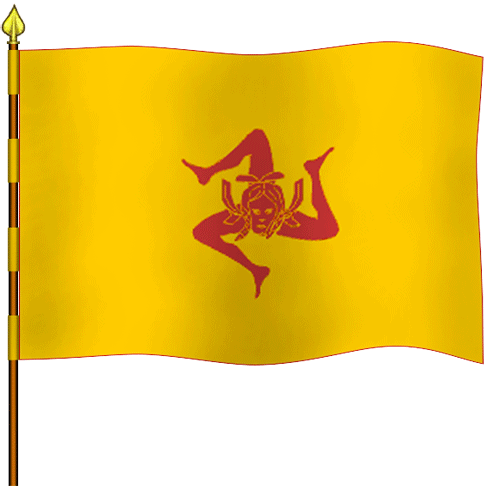
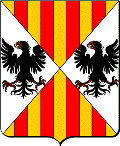 |
Via Centuripe, 11 - 94100 ENNA | Telefono 327.0155325 oppure pusi@ennaonline.com
LA GUERRA DEL VESPRO E LA PACE DI CALTABELLOTTA
del prof. Corrado Mirto
PRIMA PARTE
Durante la guerra del Vespro si scontrarono due coalizioni: una, che potremmo chiamare filosiciliana, che all'inizio era formata dalla Sicilia e dal regno d'Aragona; un'altra, che potremmo chiamare filoangioina, che era formata dal regno di Napoli, dai guelfi italiani, dal papato e dal regno di Francia.
Introduzione
Le due coalizioni non rimasero uguali nel tempo e, dopo il 1295, con il passaggio del regno d'Aragona nel campo filo-angioino, la Sicilia rimase sola a difendere la propria indipendenza. Durante il periodo dell'alleanza con il regno di Aragona, la Sicilia non era una appendice dell'Aragona ma, pur essendo un regno meno forte di quello alleato, era militarmente efficiente. La validità di questa affermazione è dimostrata dalla battaglia navale che si svolse nel 1285 nel golfo di Rosas, quando l'Aragona fu invasa da un esercito francese.
Nel mese di maggio del 1285 un grande esercito preparato dalla Francia arrivò ai Pirenei per invadere l'Aragona. Pietro III con poche forze riuscì a fermarlo per una ventina di giorni; poi anche l'ostacolo della catena montuosa fu superato e l'esercito francese pose assedio alla città fortificata di Gerona. Il re d'Aragona diede allora inizio a serrate azioni di guerriglia contro gli assedianti e contro i rifornimenti che arrivavano al nemico per via di terra. Però era anche necessario bloccare anche i viveri che arrivavano ai Francesi per via di mare e, alla fine di maggio, divennero pressanti le richieste aragonesi al governo siciliano perché la flotta siciliana intervenisse in aiuto dell'Aragona. Finalmente, a metà agosto, trentasei galee siciliane partirono agli ordini dell'ammiraglio Ruggero Lauria e il 24 dello stesso mese approdarono a Barcellona.
Ripartirono dopo tre giorni assieme a dodici galee catalane e, in prossimità del golfo di Rosas, a nord di Gerona, la flotta alleata, formata per tre quarti da navi siciliane, sorprese la flotta francese. Nel mare di Catalogna risuonò il grido di «Aragona e Sicilia» e le navi francesi furono sbaragliate. Solo dodici galee riuscirono nella confusione a mettersi in salvo passando fra le navi nemiche al grido di «Aragona e Sicilia», facendosi scambiare così per navi siculo catalane. La pace di Caltabellotta non pose fine alla guerra del Vespro, come normalmente si legge nei manuali di storia, ma soltanto alla prima parte della guerra.
La guerra del Vespro, infatti, si concluse settanta anni dopo, nel 1372, quando, dopo lunghe trattative, l'accordo per una pace definitiva fu raggiunto dal re di Sicilia Federico IV e dalla regina di Napoli Giovanna I, grazie anche alla mediazione del papa Gregorio XI che era deciso a porre fine a una guerra che durava ormai da novant'anni. La pace di Caltabellotta non fu stipulata da Angioini e Aragonesi, come troppo spesso si legge nei libri di storia, per il semplice fatto che Angioini e Aragonesi in questa fase della guerra non erano nemici, ma alleati contro la Sicilia, e la pace può esser fatta solo tra nemici, non tra amici che già sono in pace e non in guerra.
L'accordo invece fu fatto tra Siciliani e Angioini. Ma siccome da centocinquant'anni "Sicilia delenda est", cioè la Sicilia deve scomparire come soggetto della storia e il Popolo Siciliano deve essere considerato non come protagonista della sua storia ma come oggetto inerte delle iniziative altrui, fu necessario cancellare i Siciliani dall'elenco dei protagonisti della pace di Caltabellotta e mettere al loro posto gli Aragonesi. La pace di Caltabellotta non fu stipulata grazie alla mediazione di Bonifacio VIII, il quale non sapeva niente di quella trattativa, non era favorevole alla fine della guerra contro la Sicilia, e in seguito, quando incontrò Carlo di Valois, che aveva firmato quell'accordo, ebbe con lui quello che in politica si chiama "un franco colloquio", cioè un incontro tempestoso con recriminazioni e insulti.
L'inizio della rivoluzione
Il 31 marzo del 1282 a Palermo divampò contro gli Angioini la rivolta che si estese, con grande rapidità, prima ai centri vicini poi a quelli più lontani. Il 5 aprile le bandiere della libera Sicilia sventolavano anche nella parte sud orientale dell'Isola, a Modica, Ragusa e Scicli. Il 28 aprile pure Messina, sede del governatore angioino della Sicilia, cacciò i dominatori stranieri. In meno di un mese quindi tutta la Sicilia si era liberata. Alla fine di luglio un grande esercito angioino investì Messina che si difese con un valore che, a volte, divenne esaltazione mistica. Si dava per certo che la Madonna era apparsa sulle mura assieme ai difensori; l'abbondanza di pesce che veniva pescato faceva pensare alla pesca miracolosa di cui parlano i Vangeli, l'estate stranamente piovosa rese possibile dentro le mura la produzione di ortaggi e rendeva certi della protezione divina.
Bartolomeo di Neocastro, un cronista contemporaneo, facendo sfoggio di cultura religiosa, scriveva: «Pluet Dominus mel et lac a coeli nubibus super terram, et ex alto nutriet Dominus plebem suam». Cioè: «Il Signore farà piovere miele e latte dalle nubi del cielo sulla terra e dall'alto nutrirà il suo popolo». Intanto il parlamento siciliano riunito a Palermo decise di offrire la Corona di Sicilia a Pietro III d'Aragona, che era il marito di Costanza, figlia di Manfredi, ultimo re di Sicilia. Pietro III accettò l'offerta e il 30 agosto 1282 sbarcò a Trapani accolto con grande festa.
In realtà le forze che arrivarono con lui erano modeste: si trattava di una trentina di navi che portavano poche centinaia di cavalieri e poche migliaia di fanti, i quali erano anche "sfardati", cioè con i vestiti logori, ma si trattava sempre di un sostegno militare. Pietro III, viaggiando per via di terra, arrivò a Palermo il 4 settembre. Le accoglienze riservate dai Palermitani al marito della loro regina furono trionfali. Infatti, andarono a incontrarlo sei chilometri fuori delle mura.
Il cronista Saba Malaspina scrive che, quando il nuovo re di Sicilia entrò nella capitale del Regno, il clamore della folla e il suono delle trombe si sentivano fino a Monreale. Alla fine di settembre, all'avvicinarsi di un esercito siculo-aragonese, Carlo I d'Angiò ordinò la ritirata alle truppe che assediavano Messina. Il 2 ottobre del 1282 Pietro III entrò nella città dello Stretto, mentre i siculo-aragonesi passavano all'offensiva in Calabria.
La battaglia di Napoli
Nella primavera del 1284 Carlo I andò in Provenza per raccogliere denaro e preparare uomini e navi per una grande offensiva contro la Sicilia prevista per l'estate. Lasciò a Napoli come reggente il figlio Carlo lo Zoppo, ma gli ordinò di non prendere nessuna iniziativa prima del suo ritorno. Non aveva infatti nessuna fiducia nel figlio che non stimava e in modo particolare non amava perché molto diverso da lui. Carlo lo Zoppo era mite e il padre scambiava la mitezza per inettitudine.
Il figlio poi non approvava gli spietati sistemi di governo del genitore e, divenuto re, in una lettera del 10 agosto 1298 scrisse di essere convinto che la rivolta siciliana era scoppiata per la sfrenata licenza degli ufficiali di suo padre. In Sicilia le notizie riguardanti i preparativi nemici avevano destato preoccupazione, anche per le difficoltà di ricevere aiuti dall'Aragona che doveva pensare alla sua difesa davanti alla prospettiva dell'invasione francese. Si decise perciò di colpire il nemico prima che avesse potuto effettuare il concentramento delle forze. Da Messina partì la flotta siciliana sotto la guida dell'ammiraglio Ruggero Lauria che godeva già di largo prestigio. Le navi siciliane arrivarono nel golfo di Napoli devastando le terre che incontravano sul loro percorso. La loro presenza provocò viva emozione e pressioni sul principe Carlo perché si assalissero le navi nemiche.
Solo pochi consiglieri, fra cui il legato pontificio, insistevano perché non si pigliasse alcuna iniziativa prima dell'arrivo del sovrano. Alla fine, Carlo lo Zoppo decise di affrontare il nemico e di guidare personalmente le sue navi. Il 5 giugno del 1284 si combatté la battaglia. Alla vista delle navi nemiche la flotta siciliana fuggì per alcune miglia, poi improvvisamente invertì la rotta e si lanciò contro di esse al grido di «Aragona e Sicilia». Prima che venissero a contatto con il nemico, gli equipaggi di diciotto navi dei regnicoli, presi dal panico, fuggirono, lasciando i Francesi soli a combattere una battaglia già perduta.
La vittoria dei Siciliani
Il principe Carlo e i suoi si difesero valorosamente nella poppa della nave ammiraglia già invasa dai nemici, i quali alla fine aprirono falle nel fondo della nave. E così, mentre la galea si inabissava, i superstiti furono costretti ad arrendersi per salvarsi. Il disastro fu completo. Dalla terra ferma una delegazione di regnicoli venne nella nave ammiraglia siciliana a congratularsi per la vittoria e a esprimere l'augurio che in seguito venisse catturato anche Carlo I. Le congratulazioni furono ricevute dal principe Carlo, che i delegati avevano scambiato per Ruggero Lauria. A Napoli scoppiarono violenti tumulti con uccisioni di Francesi. La moglie del principe Carlo aveva assistito alla battaglia navale dal suo castello sulla riva del mare, aveva visto le navi in fuga e l'ammiraglia affondare, ed era per questo preoccupata per la sorte del marito. Ebbe notizie del principe Carlo da due galee siciliane che approdarono presso il castello.
I Siciliani portarono una lettera di Carlo nella quale si ordinava di liberare dal carcere una figlia di Manfredi, Beatrice, sorella della regina Costanza, che, rinchiusa in prigione nel 1266 dopo la sconfitta e la morte del padre, dopo diciotto anni era ancora tenuta prigioniera dal diletto figlio della Chiesa Carlo I. Per rendere la richiesta più convincente gli inviati siciliani chiarirono che se Beatrice non fosse stata liberata il principe Carlo sarebbe stato subito decapitato e, siccome con la cortesia si ottiene tutto, la povera figlia di Manfredi fu tolta dalla prigione e consegnata ai Siciliani.
Mentre nel golfo di Napoli si svolgeva la battaglia, Carlo I, con la flotta provenzale, arrivava ai confini del Regno. Appena sbarcato a Gaeta apprese la notizia della cattura del figlio. Il risentimento per la sconfitta, provocata dal fatto che non erano state rispettate le sue disposizioni, prevalse sul dolore per la prigionia e l'incerta sorte del principe. Avrebbe avuto motivo di essere molto preoccupato pensando a possibili rappresaglie per il trattamento che egli aveva riservato a Corradino di Svezia, invece dichiarò di essere dispiaciuto più per la perdita della flotta che per la cattura del figlio.
Aggiunse che sarebbe stato meglio che il principe fosse morto, poiché non aveva ubbidito ai suoi ordini. Arrivò a Napoli con un umore nerissimo. Voleva incendiare la città per punirla dei disordini contro i Francesi; alla fine, per le pressioni dei nobili e del legato pontificio, si limitò a fare impiccare circa centocinquanta persone. Il 14 giugno scrisse una lettera trionfalistica al comune di Pisa, comunicando che le navi nemiche erano fuggite e che la cattura del principe non era un colpo grave perché egli aveva molti eredi, figli di suo figlio. Informò inoltre i Pisani che a Napoli aveva cinquantaquattro galee, sette galeoni e molte navi, a Brindisi venticinque galee e settanta teride, a Nicotera sette teride. Conclude scrivendo che si stava preparando a partire per lo sterminio dei ribelli.
La reazione di Carlo I
Carlo I presto passò dalle minacce ai fatti. La flotta raccolta a Napoli ebbe l'ordine di partire, di circumnavigare la Sicilia e di ricongiungersi presso le coste calabresi con l'altra flotta proveniente da Brindisi. Il re scese con diecimila cavalieri e quarantamila fanti per via di terra verso il sud e, come azione preliminare allo sbarco in Sicilia, verso metà di luglio del 1284 pose l'assedio a Reggio Calabria che dal mare veniva bloccata da circa duecento navi. Pietro III preoccupato per le notizie che gli erano pervenute sull'entità dei preparativi nemici, malgrado le sue difficoltà in Aragona, mandò quattordici galee in soccorso della Sicilia.
Nei piani di Carlo I la conquista di Reggio Calabria, città fornita di modeste fortificazioni, doveva avvenire in pochi giorni. Invece la mastodontica spedizione non riusciva a superare l'ostacolo e il piccolo presidio siculo-aragonese resisteva, così che la conquista della città divenne lo scopo principale dell'offensiva. Durante l'assedio si vide che qualcosa non funzionava nella enorme macchina militare angioina. Vi era difficoltà a rifornire di viveri una così grande massa di combattenti; gli uomini, poi, raccolti da tanti paesi diversi (regno di Francia, Provenza, Italia centro-settentrionale, regno di Napoli), si battevano senza alcun entusiasmo. Ad agosto cominciarono le diserzioni in massa dall'esercito angioino.
Carlo I reagì nell'unico modo che gli era congeniale: con il terrore. Ordinò che ai saraceni di Lucera che disertavano fosse tagliato un piede, a scelta dell'autorità competente. Ai fratelli cristiani disertori fu invece riservato un trattamento di particolare favore: il piede da amputare era il sinistro. Da un po' di tempo però il collaudato sistema del terrore non funzionava più: la dissoluzione dell'esercito angioino continuò. Allora a Carlo I non restò che ordinare la ritirata, che fu giustificata con la difficoltà dei rifornimenti e fu resa meno amara con l'assicurazione che nella primavera successiva vi sarebbe stata l'offensiva definitiva contro i ribelli. Il re angioino però non sapeva che prima della primavera del 1285 avrebbe avuto ben altri problemi: avrebbe dovuto giustificare davanti alla Giustizia divina l'operato della sua vita. Carlo I, infatti, morirà qualche mese dopo a Foggia il 7 gennaio 1285.
L'alleanza con l'Aragona
L'undici novembre del 1285 morì anche Pietro III. Gli successero i figli Alfonso III in Aragona e Giacomo II in Sicilia. Pochi giorni dopo la morte di Pietro III, Alfonso III affidò a Ruggero Lauria, in procinto di partire da Maiorca per la Sicilia, l'incarico di proporre una alleanza fra l'Aragona e la Sicilia. In base a questa alleanza i due regni si mettevano su un piano di parità e si promettevano aiuto reciproco. L'Aragona, però, traeva maggiore vantaggio dall'alleanza perché, mentre assicurava aiuto soltanto per la difesa della Sicilia, ne chiedeva per la difesa dell'Aragona e anche per nuove conquiste.
Il governo siciliano, che aveva bisogno dell'aiuto aragonese, non sottilizzò sulla formula. Ruggero Lauria portò in Sicilia il documento con il quale Alfonso si impegnava con giuramento a difendere la Sicilia con tutte le sue forze (entrando quindi in guerra direttamente) contro chiunque (quindi anche contro il papa). Pochi giorni dopo la sua in-coronazione, il 12 febbraio del 1286, Giacomo II a sua volta giurò di sostenere il regno d'Aragona, anche per nuove conquiste, con tutte le sue forze e contro chiunque. Si creava così una stretta alleanza fra la Sicilia e l'Aragona. In questo periodo ci fu una nuova vittoria navale dei Siciliani. Alla fine della primavera del 1287 Ruggero Lauria, arrivato con la flotta siciliana nel golfo di Napoli, scrisse all'ammiraglio angioino una lettera provocatoria intimandogli di prepararsi perché il 23 giugno lo avrebbe assalito.
E, infatti, il 23 giugno del 1287 quaranta galee siciliane si scontrarono nel golfo di Napoli con ottantaquattro fra galee e teride nemiche. La battaglia fu dura, ma si concluse con un trionfo per la flotta siciliana che catturò quarantaquattro navi nemiche e cinquemila prigionieri.
Il trionfo fu di tutta la Sicilia perché le navi che formavano la flotta siciliana erano affluite da tutte le parti dell'Isola. Le fonti, senza avere l'intenzione di fare un elenco completo dei centri di provenienza, parlano di galee provenienti da Messina, Milazzo, Lipari, Trapani, Siracusa, Catania, Augusta, Taormina, Cefalù, Gela, Licata e Sciacca. E sicuramente vi erano anche galee provenienti da Palermo.
Intanto, spinto dal malcontento dei suoi sudditi che non volevano continuare una guerra che veniva combattuta soltanto per sostenere l'alleato siciliano, Alfonso III cominciò a trattare con i nemici. Il risultato di quelle trattative fu l'accordo di Brignoles del 19 febbraio 1291, con il quale l'Aragona, per ottenere la pace, non soltanto lasciò l'alleanza con la Sicilia, ma si impegnò an-che, se fosse stato necessario, a intervenire militarmente contro i Siciliani. Il programma però non poté essere attuato perché il 18 giugno del 1291 Alfonso III, solo dopo tre giorni di malattia, morì all'età di ventisette anni.
Corrado Mirto (1 - continua)
Vespro Siciliano
Approfondimenti
